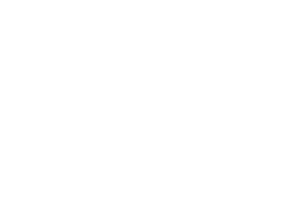di Sofia Farina
Come gli uccelli, premiato con l’Ubu per il miglior nuovo testo straniero, è un’opera di teatro contemporaneo che scardina ogni aspettativa. Quello che inizialmente sembra il racconto di una storia d’amore tra due giovani studenti universitari si trasforma presto in una dolorosa dissezione dell’identità, della memoria, del pregiudizio e dell’eredità invisibile che ci costringe, spesso, a diventare qualcosa che non siamo.
La vicenda prende avvio in una biblioteca universitaria di New York, tra scaffali polverosi e luci fredde. Qui, Eitan, brillante studente ebreo tedesco, conosce Wahida, una ragazza araba, affilata e schiva, priva di una genealogia familiare chiara. L’approccio di Eitan è maldestro, quasi imbarazzante, ma è proprio questa tensione iniziale a dar vita a una relazione imprevedibile. Dopo una serata in discoteca, tra risate e imbarazzi, i due iniziano a frequentarsi, a conoscersi. Ma il loro amore nasce nel cuore di un campo minato: quello delle identità.
La struttura narrativa, però, è ingannevole. Tutto ciò che vediamo nei primi momenti non accade in tempo reale. Lo scopriamo presto: Eitan è rimasto ferito in un attentato mentre aspettava Wahida alla dogana tra Israele e Giordania. Lei era stata fermata per un controllo in un bar. Una bomba è esplosa. Ora Eitan è in coma, e Wahida è accanto a lui, in un ospedale israeliano, e tutto ciò che sappiamo ci viene raccontato attraverso la sua voce, mentre veglia su di lui, mentre cerca di dare un senso al passato e al presente.
Wahida era arrivata in Israele per una ricerca accademica: vuole riscrivere la biografia dimenticata di un diplomatico arabo, Hassan Ibn Mahammed Al-Wazzân, vissuto cinquecento anni prima. Egli fu catturato e donato al papa, il quale gli restituisce la libertà in cambio della conversione. Così l’uomo cambia identità e vita, ma ritornato in patria si perde ogni traccia di lui. Eitan, invece, aveva deciso di accompagnarla, ma con un secondo scopo, intimo e doloroso: incontrare Leah, la donna che potrebbe essere la madre biologica di suo padre, David. Il viaggio, però, viene stravolto dall’esplosione che li separa.
Nel tempo sospeso dell’ospedale, entra in scena la verità. Wahida, nel suo sforzo di ricucire i fili spezzati, contatta Leah. Inizialmente la donna le sbatte la porta in faccia, ma successivamente la ragazza si fa valere e le racconta del tentativo di Eitan di presentarla ai suoi genitori e suo nonno Etgar. Tuttavia questo incontro non era mai avvenuto, in quanto David la vedeva come un nemico e da lì si era aperta una profonda discussione sull’eredità genetica e sull’identità di gruppo, per poi sfociare in una violenta lite. Leah avvisa Etgar e tutta la famiglia si precipita a Gerusalemme. Insieme, Leah ed Etgar decidono di rivelare a Eitan una verità mai detta: David non è figlio loro. Etgar lo aveva trovato in campo nemico, solo, un bambino arabo, e insieme a Leah lo ha cresciuto come figlio, fingendo che fosse frutto del loro matrimonio. David è arabo. Totalmente. Una verità che hanno nascosto per decenni, persino a se stessi.
Quando Eitan si risveglia, la verità lo accoglie come una seconda esplosione. Ma non è a lui che pesa di più. È David a essere devastato. Dopo aver passato la vita a difendere e imporsi un’identità ebraica, dopo aver rifiutato con violenza la relazione del figlio con una donna araba, scopre di esserlo lui stesso. Tutto ciò su cui aveva costruito la sua esistenza crolla.
Sarà Etgar a comunicarglielo. E David non regge. Non urla. Non si dispera. Smette semplicemente di vivere. Si lascia morire, come se accettare quella verità fosse impossibile. Ma prima di spirare, viene compiuto un gesto di compassione: Wahida viene chiamata a parlare con lui. In arabo. Nella lingua che David non ha mai conosciuto, ma che è sua. L’ultima scena è straziante: Wahida, la ragazza respinta, accompagna l’uomo che l’ha rifiutata verso la morte con le parole della sua infanzia perduta. Un atto di pace e di amore, che arriva quando ormai è troppo tardi per riparare.
La forza dello spettacolo sta anche nella sua scenografia essenziale ma potentissima. Un grande muro, che taglia lo spazio e domina il palco, è presente dall’inizio alla fine. Su di esso si proiettano parole in arabo, ebraico, tedesco. È un muro fisico e simbolico: è il confine tra le lingue, le culture, le verità. È il muro che separa i vivi dai morti, il presente dal passato. Ma come gli uccelli del titolo, i protagonisti tentano — a volte invano — di volare sopra quel muro, di trovare una via che non sia né fuga né negazione, ma elaborazione e libertà.
I salti temporali sono continui, ma sempre chiari, segnati con eleganza visiva. Il tempo, in questo testo, non è mai lineare: è memoria, è trauma, è ritorno. E i dialoghi — cesellati con cura estrema — non sono mai didascalici. Federico Palumieri e Lucrezia Forni, nei ruoli di Eitan e Wahida, offrono interpretazioni intense e complesse, capaci di restituire la precarietà e la profondità dei loro personaggi.
Il titolo Come gli uccelli è, alla fine, un invito: a guardare oltre. Gli uccelli, si dice, non hanno patria, ma hanno direzione. Volano sopra i confini, ma non ignorano la terra. Lo spettacolo ci chiede: possiamo amare se non sappiamo chi siamo? E se la verità che scopriamo ci distrugge, possiamo ancora scegliere di vivere?
Come gli uccelli non offre risposte. Ma le domande che lascia cadere sono destinate a restare con lo spettatore molto a lungo.
Sofia Farina